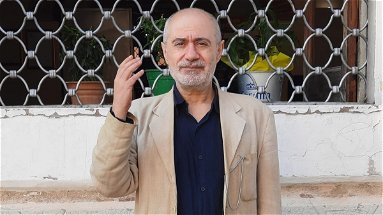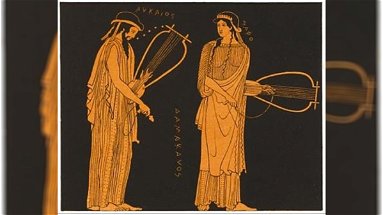Dirimpettai di Napoleone
Una fulminea galoppata e poche brevi soste lungo il sentiero di passioni che Bonaparte incise nel petto dei mortali

Ognuno di noi si trova nel raggio dello sguardo e nella nube del giudizio di tre specie di dirimpettai: il dirimpettaio disinteressato, quello benevolo, quello malevolo. Quasi inutile a aggiungersi, ognuno di noi è sua volta sguardo e giudizio, cioè dirimpettaio del prossimo. Forse l’unicità di Bonaparte stette tutta nel fatto che ci si poté, sì, fingere indifferenti a lui, ma esserlo davvero fu ed è cosa impossibile. Non per nulla qualcuno lo disse “segno d’immensa invidia / e di pietà profonda, / d’inestinguibil odio / e d’indomato amor.”
Quando, nel Febbraio del 1797, Bonaparte passò per Recanati costeggiando palazzo Leopardi, il conte Monaldo, poco più che ventenne, non s’affacciò nemmeno, “giudicando non doversi a quel tristo l’onore che un galantuomo si alzasse per vederlo”, come avrà a scrivere nell’Autobiografia.
La Rivoluzione francese fu un dono che gli dei fecero agli uomini, e Bonaparte, che la condusse a perfezione, fu, tra i mortali, il più grande; la Rivoluzione francese fu il più funesto dei flagelli, e Bonaparte il più grande degli uomini poiché ne fugò dalla terra ogni mefitico effetto; fu la Rivoluzione la grazia che racchiude ogni grazia, e Bonaparte fu il serpe che la tradì; la Rivoluzione fu un grandissimo male, e Bonaparte, che la perfezionò e la sparse per il mondo, fu il Male stesso. Lo spazio aperto da queste quattro proposizioni contiene ogni giudizio possibile sull’uomo che chiuse gli occhi a Sant’Elena in questo stesso giorno di duecento anni fa. Se scrissi “in questo stesso giorno” è perché codesto articoletto è destinato, sì, a uscire domenica nove Maggio, ma lo vado stendendo il pomeriggio del cinque. Spirò alle 17 49, Napoleone, secondo l’ora di Sant’Elena, e ogni orologio di casa mi segnala che sono le 17 41… Suggestione assai facile, certo: ma non seppi resisterle.
Se Monaldo Leopardi era giovane solo di anni quando sdegnò di concedere uno sguardo al generale Bonaparte, giovane d’anni e d’anima era il poeta tedesco che al generale vittorioso dedicò una lirica il cui titolo non ne francesizza il cognome. È Buonaparte, infatti, il titolo in questione. L’autore, Friedrich Hölderlin. Il testo, composto nel 1799, qui riportiamo nella traduzione di Giorgio Vigolo (F. Hölderlin, Poesie, Einaudi 1963, p. 34): “Vasi sacri sono i poeti, / Dove il vino della vita, lo spirito / Degli eroi si conserva. // Ma lo spirito di questo giovane, / Fulmineo, non farebbe schiantare / Ove volesse contenerlo, il vaso? // Non si attenti con lui il poeta, come con lo spirito della natura, / In tale campo diventa allievo il maestro. // Egli non può nel poema vivere e perdurare, / Vive e perdura nel mondo.”
Se in Occidente non era possibile ad alcuno esser contemporaneo di Napoleone senza patirne l’influsso, un altro gigante, e cioè il principe della prosa francese della prima metà dell’Ottocento, con Napoleone primo console e poi imperatore ebbe a ingaggiare un duello di reciproca ammirazione e reciproca ira. Lo scrittore temeva l’onnipotenza del despota, e il despota temeva l’incorruttibilità dello scrittore e la sua indipendenza di giudizio. Lo scrittore è François René de Chateaubriand. Nei primi mesi del 1814, mentre l’imperatore, con brillanti ma inutili vittorie, tentava di vanificare gli effetti della disastrosa sconfitta di Lipsia, Chateaubriand febbrilmente scriveva un libello in cui Napoleone è chiamato Buonaparte per pura volontà di disprezzo. De Buonaparte et des Bourbons ne è infatti il titolo. Caldamente auspicando il ritorno del sovrano legittimo, l’autore dipinge un Bonaparte rozzo quanto aggressivo, venuto su da una “famiglia semiafricana”, invidiosissimo della grandezza altrui, pessimo amministratore, pessimo politico, generale valente solo perché la Francia era assai popolosa ed egli, con la coscrizione obbligatoria e nel più pieno disprezzo della vita altrui, ne falcidiò tra marce forzate e battaglie la gioventù virile. Nei Mémoires d’outre-tombe Chateaubriand ritornerà su Bonaparte, ne ridisegnerà il profilo, si tenterà equanime sia pur nell’elegante narcisismo che pulsa nel sontuoso drappeggio del suo dettato.
Aprimmo questo articolo con un conato di disprezzo sdegnoso, lo chiuderemo con un conato di disprezzo bizzoso. Carlo Emilio Gadda, onnipossente umorale prosatore, ne Il primo libro delle favole(1952) lancia alcune secchiate di gaia istruttiva stimolantissima bile su alcuni tipi che aveva in uggia grande: Mussolini, Bruno Pontecorvo, il Poliziano, il Carducci, ecc. Breve premessa indispensabile: chi legge troverà “collo” dove s’aspetterebbe “colle”. Non è svista o refuso, ma una delle tante forme arcaiche che l’iracondo Gadda godeva a impastare sul foglio a ogni altra croma della lingua per aggredire la lingua stessa e la realtà, e per fare felice il lettore sfiancandolo. Sentiamo Gadda: “Quando il collo di Cadibona vide arrivar su il generale Bonaparte, disse: ‘e va bé’.’’ L’inquinamento e la bomba all’idrogeno hanno insegnato al pianeta e ai suoi cieli che l’uomo è sporcaccione. Invocare però il disinteresse del pianeta o di una sua protuberanza all’epocale passaggio di un uomo epocale palesa stizza e disappunto, ma non rimpicciolisce chi passò.